
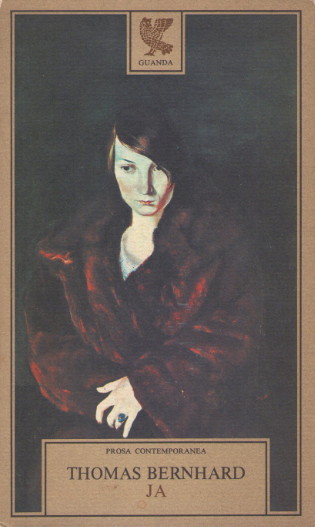
| Ja |
| © 1978 SUHRKAMP VERLAG, FRANKFURT AM MAIN |
| Ja |
| traduzione di Claudio Groff |
| Guanda - Prosa contemporanea 19 |
| Prima edizione: 1983 - 105 pagine -
12 x 20 cm. |
| © 1983 UGO GUANDA EDITORE S.P.A., MILANO |
| CL 84-0201-9 |
| I protagonisti
di Ja sono quattro anziane persone: una coppia
(lui è un costruttore svizzero e lei è
persiana), un agente immobiliare e uno
studioso di scienze naturali. Quest’ultimo ci
racconta la vicenda, con una straordinaria
capacità di affabulazione: egli ci risucchia
nelle sue spire e non ci lascia più. Il suo
racconto si configura come una specie di
scommessa – per vigore e continuità e
capacità di intrecciare il poco che possa
accadere in un sonnolento villaggio austriaco
dove un uomo continua a fare il suo mestiere
che è quello di vendere terreni, un altro a
dibattersi nel suo eterno rifiuto della scho-
penhaueriana «volontà di vivere» e altri due
acquistano arrivando da fuori la funzione di
allarme. Così, mentre il racconto equivale ad
un tuffo ad una profondità inconcepibile,
discesa in apnea praticamente illimitata, ciò
che esso viene scoprendo (prima a se stesso
che all’eventuale ascoltatore) è un mondo di
solitudini in cui l’atto esistenziale di
maggior senso è quello del confessarsi a
qualcuno. Ad un certo punto l’isolamento
fisico e morale diventa insostenibile: ed ecco
che lo scienziato parla della propria
«infermità» all’agente immobiliare,
bruscamente e brutalmente coinvolgendolo
(dunque – non salvandolo e non salvando se
stesso per la sua mancanza di delicatezza); ed
ecco che, in un secondo momento, tutto si
ripete – quando la persiana, più o meno allo
stesso modo ansioso e solipsistico,
confesserà il proprio fallimento
esistenziale, quello del suo quasi matrimonio
e quello della sua idea «molto orientale» di
sacrificio per un uomo. Si potrebbe insinuare
che anche questa c una economia – una economia
dello spirito umano. Ma non sempre
l’autosvelamento produce un beneficio. Il
narratore è colui che in qualche modo ne ha
tratto vantaggio: in lui, parlare di sé,
contrapporre l’altro a se stesso, fu causa di
un ripristino del circuito vitale interrotto:
prima la parola, poi la lettura, infine la
possibilità di tuffarsi negli studi – in una
parola la possibilità di nuovamente «creare».
Ma per la donna non è andata così: in fondo al
suo tentativo c’era altra solitudine, anzi una
solitudine definitiva. Ed è qui,
probabilmente, che si svela, a noi, il senso
del testo di Bernhard: quasi inevitabile
contrapporre il suo «sì» finale all’altro
celebre «sì» finale della letteratura, quello
dell’Ulisse. Il confronto avviene,
naturalmente, solo sul piano del senso. Ma è
curioso osservare come nel grande romanzo di
Joyce il «sì» si contrapponga all’«universo
della morte» di cui parlò Henry Miller e nel
breve romanzo di Bernhard il «sì» non
introduca né designi alcun rovesciamento
strutturale – come forse pretende. Esso non è
che il compimento o la summa di uno stile che
tende all’autoconservazione, alla maniacale
affermazione di sé – non certo un elemento
dialettico o, meglio, ambiguo. Bernhard è uno
scrittore tutto definito dallo stile. Si
direbbe anzi che la sua narrativa sia la
messinscena di un conflitto ad effetto: quello
tra una visione tremendistica del mondo
(infine, fatalmente, filistea) e una scrittura
che proprio nel suo mimetico piétiner sur
place, cioè con un paradosso, intende
realizzare il superamento del vischioso dato
iniziale. Thomas Bernhard, nato nel 1931, vive a Ohlsdorf, nell’Austria Superiore. Nel 1970 ebbe il Premio Büchner. La sua opera di narratore, oggetto sin dall’inizio di intensa attenzione da parte dei critici, comprende romanzi e racconti, tra cui: Frost (1963), Amras (1964), Verstörung (1967), An der Baumgrenze ( 1969), Das Kalkwerk ( 1970), Midland in Stilfs (1971), Korrektur (1975). Ha scritto anche poesie, e una lunga serie di lavori teatrali, parecchi dei quali presentati al Festival di Salisburgo (a partire dal 1972); di essi è stato detto che «rappresentano le prime commedie tedesche da tempo immemorabile». La Guanda ha presentato per prima in Italia lo scrittore austriaco pubblicando, nel 1981, i racconti de L’Italiano. |
| In copertina: Wilhelm Lachnit, Donna in pelliccia, 1925. |