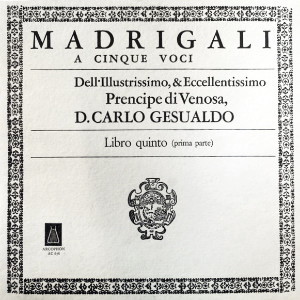 |
|
1 LP -
AC 676 - (p) 1965
|
 |
| 1 CD -
CRA 8912-5 - (c) 1996 |
|
Carlo
GESUALDO da Venosa (1566-1613)
|
|
|
|
|
|
| MADRIGALI
A CINQUE VOCI, LIBRO V (1611) -
prima parte |
|
|
|
|
|
| -
Gioite voi col canto |
4' 17" |
|
| - S'io non miro
non moro |
3' 43" |
|
| - Itene o miei
sospiri |
3' 16" |
|
| - Dolcissima
mia vita |
3' 07" |
|
| - O dolorosa
gioia |
4' 12" |
|
| -
Qual fora, donna |
2' 27" |
|
|
|
|
| -
Felicissimo sonno |
3' 23" |
|
| - Se vi duole
il mio duolo |
3' 47" |
|
| - Occhi del
mio cor vita |
2' 52" |
|
| - Languisce
alfin |
4' 19" |
|
| -
Mercè grido piangendo |
3' 06" |
|
| - O voi troppo
felici |
2' 00" |
|
| - Correte,
amanti, a prova |
2' 10" |
|
|
|
|
| QUINTETTO VOCALE
ITALIANO /
Angelo Ephrikian, direttore |
|
| - Karla
Schlean, soprano |
|
| - Rosanna Giancola,
mezzosoprano |
|
| - Clara
Foti, contralto |
|
| - Rodolfo
Farolfi, tenore |
|
| - Gastone
Sarti, basso |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Villa
Litta, Milano (Italia) - 20-27
maggio 1965 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Giambattista
Pirelli / Karla Schlean - Angelo
Ephrikian |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Arcophon
- AC 676 - (1 LP) - durata 42' 43"
- (p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizione CD |
|
Rivo
Alto & Electa "Musica e Musei"
- CRA 8912-5 - (1 CD) - durata 67'
07" - (c) 1996 - ADD |
|
|
Note |
|
In
copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera
degli Sposi (particolare) -
Palazzo Ducale - Mantova
L'edizione in CD contiene l'intero
Quinto Libro mentre l'edizione in
Lp contiene i primi 13 numeri.
|
|
|
|
|
IL
QUINTO LIBRO DEI MADRIGALI
Il quinto e il sesto libro dei
madrigali del Principe di Venosa
furono pubblicati quasi
contemporaneamente a Gesualdo
nel 1611, per i tipi di G.G.
Carlino e per cura di tale
Giovanni Pietro Cappuccio, certo
un cortigiano del principe che -
secondo la consuetudine - dedicò
la raccolta allo stesso
compositore: si trattava
ovviamente di una finzione resa
necessaria dal costume del tempo
che vietava a un personaggio del
rango del Venosa di assumere
direttamente la responsabilità
della pubblicazione delle
proprie opere.
La data di composizione dei
madrigali raccolti nel quinto e
nel sesto libro si scagliona
presumibilmente lungo un arco di
tempo assai ampio, come si
deduce tra l’altro dalla dedica
del sesto libro al Gesualdo,
stesa dallo stesso Giovanni
Pietro Cappuccio: "Questi
madrigali della sesta muta
furono composti da V.E. nelli
medesimi anni che furono quelli
della quinta; e perciò questi
ancora sono stati aspettati con
grandissimo desiderio dal mondo
da sì lungo tempo". Si tratta
dunque di una scelta che
Gesualdo stesso compì delle
proprie opere composte dopo il
1596, con la consueta severità e
l’acuto senso critico che gli
vietò, per esempio, di divulgare
i suoi esperimenti in stile
monodico di cui è fatta menzione
da parte del Fontanelli (cfr. la
mia presentazione del III° Libro
dei Madrigali di Gesualdo, Disco
Ars Nova VST 6197) e le
canzonette pubblicate postume da
Pomponio Nenna nel proprio Ottavo
Libro dei Madrigali, Roma,
1618.
Nella sua critica vicenda
esistenziale che dovette
assumere negli ultimi anni
aspetti e momenti veramente
allucinanti, la musica non cessò
di essere un polo costante di
interesse, un campo di studio e
di ricerca assidua e febbrile,
nella quale Gesualdo impegnò la
parte rnigliore di se, le sue
lucide doti intellettuali non
meno dell’appassionata dedizione
interiore. Tornato a Napoli nel
1597, raccolse intorno a se
un’accademia musicale
comprendente Scipione Stella,
Rocco Rodio, Pomponio Nenna,
Muzio Efrem, Giovanni Macque,
Bartolomeo Roy, Giovambattista
di Pavolo, Scipione Cerreto,
Giustiniano Forcella, Domenico
Montella, "compositori, sonatori
e cantori eccellentissimi" che
il principe, secondo le parole
di un contemporaneo "per suo
gusto e intertenimento tiene in
sua corte a sue spese". Gesualdo
preso tutto dalla sua passione,
ignorava le accuse di eccessiva
prodigalità e di sperpero che la
sua famiglia gli moveva. Egli,
pontefice in questo eletto
cenacolo d’artisti, mirava certo
ad emulare i fasti musicali
della corte estense: desiderio
confermato dalla fondazione, nel
castello di Gesualdo, di una
stamperia musicale diretta da
G.G. Carlino, la stessa che
pubblicò i suoi due ultimi libri
di madrigali e una sua raccolta
di responsori.
Gesualdo volle consolidare la
sua fama di compositore,
pubblicando tra il quarto (1596)
e il quinto (1611) libro di
madrigali tre raccolte di musica
religiosa: Sacrarum
Cantionum Quinque Vocibus
Liber Primus (1603); Sucrarum
Cantionum Liber Primus Quarum
Una Septem Vocibus, Ceterae
Sex Vocibus Singulari
Artificio Compositae
(1603); Responsoria et Alia
ad Officium Hebdomadae Sanctae
Spectantia, a sei voci
(1611). Opere tutte, a parte
ogni ricerca di carattere
espressivo, veramente "singulari
artificio composiate",
sulla linea della più rigorosa
arte contrappuntistica
cinquecentesca. Per quanto più
propriamente concerne le ultime
due raccolte di madrigali, si
nota una sostanziale
continuazione degli
atteggiamenti espressivi
maturati nei libri precedenti,
soprattutto nel quarto. Nella
scelta dei testi incontriamo
ancora la predilezione per
poesie brevi e di limitate
pretese letterarie (nel Quinto
Libro, su ventuno madrigali, uno
solo, l’ultimo, è dovuto a un
autore illustre, Giovanbattista
Guarini). In questo modo
Gesualdo si riserva da parte sua
la massima possibilità
d’intervento, sia dal punto di
vista di un’autonoma
organizzazione strutturale del
madrigale, sia da quello di una
totale ricreazione semantica del
contenuto espressivo della
poesia. Secondo la ine notazione
critica di Nino Pirrotta "non
“serva” ma “compagna”
dell’orazione, la musica ha il
compito di dire ciò che è
indicibile a parole, di
esprimere coi rivolgimenti
cromatici il torcersi dell’anima
nel dolore, con i salti melodici
violenti e inconsueti la sfida
del sarcasmo e della ribellione,
con i travolgenti contrappunti
di diatoniche colorature di
quest’ultimo periodo... il
fervore disperato della speranza
o il dilatarsi panico della
personalità nella gioia".
I gesti espressivi si
semplificano, sino a ridursi
all’alternanza e alla
successione di atmosfere
espressive nettamente
contrastanti: è come se la
poetica espressionistica di
Gesualdo, portata alle sue
ultime conseguenze non
riconoscesse altro che la
possibilità di un procedere
apodittico, articolato
attraverso la contrapposizione
di concetti e di momenti
opposti, che solo la ferrea
logica con cui è condotto il
discorso riesce a fondere in una
struttura organica. Ancora più
sviluppato che non nel quarto
libro è il parametro armonico,
piegato ad audacie che per più
di due secoli non furono emulate
nella tradizione musicale
occidentale. Parallelamente, la
tecnica contrappuntistica si
decanta sino a raggiungere una
sorta di astratta e cristallina
purezza, soprattutto laddove
essa è impiegata in quei passi
che Vincenzo Giustiniani
definiva "fughe dolci e
correnti": momenti nei quali
Gesualdo raggiunge una gioiosa e
prorompente pienezza di vita.
Accanto a questo si delinea
negli ultimi due libri di
madrigali un tipo di
contrappunto affatto nuovo, che
potrebbe definirsi, con il
Pirrotta, "contrappunto di
recitativi, dacché la sua
sostanza non è più il gioco
delle immagini sonore in
movimento, ma la moltiplicazione
contrappuntistica dell’intensità
affettiva della declamazione".
Un calore umano tutto nuovo
hanno i passi trattati
omoritmicamente in un declamato
accordale aperto a preziose,
ricchissime sfumature di senso,
e, in generale, a un accento di
straordinaria immediatezza e
verità umane.
Anche da un punto di vista
contenutistico le due ultime
raccolte chiudono circolarmente
la tematica estetica di
Gesualdo: suggellano, portandolo
alle ultime conseguenze, in una
sorta di apoteosi lucida, ma
pure allucinata e barocca, il
tema unico della sua arte,
l’amore. Con le parole del
Pirrotta: "Egli fu, si direbbe,
romanticamente innamorato del
complesso cerimoniale del
corteggiamento amoroso, delle
promesse deluse, delle negazioni
provocanti, delle speranze
risorgenti. La vita non gli
diede che delusioni,
incomprensioni coniugali o
troppo facili avventure
degradanti del senso. Pure il
sogno persiste fino all’ultimo,
si rinnova anzi negli ultimi
anni in una fase gioiosa che le
fasi precedenti non avevano
conosciuto".
I.
Gioite voi col
canto,
Mentre piango e sospiro,
Né dal mio lagrimar punto
respiro.
Ahi, misero mio core,
Nato sol al dolore;
Piangi, ma piangi tanto
Che vinta dal tua pianto
Sia la mia donna e poi
rivedi in lei
Gli afanni e i dolor
miei.
Non a caso questo madrigale apre
il quinto libro, dopo la lunga
pausa di silenzio susseguente al
quarto. Il testo sembra
lumeggiare il rapporto tra il
musicista e la sua arte. La
dolorosa vicenda d’affetti da
cui questa nasce e si alimenta è
incapace di risolversi
totalmente nell’atto estetico.
Ad altri, non al musicista, è
dato di gioire dinnanzi al mondo
di forme che egli crea: Gioite
voi col canto, mentre piango e
sospiro... Vista come
enuncianzione di poetica, può
interpretarsi come un ideale
collegamento alla tematica
espressiva delle precedenti
raccolte madrigalistiche, che
Gesualdo andrà approfondendo
sino alla fine della sua
esperienza compositiva.
II.
S’io non miro
non moro,
Non mirando non vivo;
Pur morto io son, né son
di vita privo.
O miracol d’amore, ahi,
strana sorte,
Che 'l viver non fia
vita, e 'l morir morte.
Il testo è un esercizio
formalistico, di gusto
tipicamente barocco, nel senso
deteriore della parola: tanto
più risalta la straordinaria
concentrazione espressiva della
musica, che infonde un accento
di verità e di fervido pathos
alle parole. Si noti
specialmente la tensione di
certe linee melodiche e la
drammatica intensità della
sezione finale.
III.
Itene, o miei sospiri,
Precipitate 'l volo
A lei che m’é cagion
d’aspri martiri.
Ditele, per pietà, del
mio gran duolo;
C'ormai ella mi sia
Come bella ancor pia,
Che l’amaro mio pianto
Cangerò, lieto, in
amoroso canto.
Il probabile modello stilistico
di questa composizione è da
identificarsi con il madrigale Itene
mie querele di Luzzasco
Luzzaschi, compreso nella Seconda
scelta dei madrigali di
questo autore pubblicati nel
1613 a Gesualdo, dallo
stampatore G.G. Carlino, certo
su istanza dello stesso da
Venosa. Se dal Luzzaschi deriva
l'impostazione strutturale del
pezzo e dalla tradizione
madrigalistica illustre e, in
particolare, da Luca Marenzio il
trattamento di parole come sospiri,
volo, bella, canto,
cangerò (in concomitanza
di quest’ultimo termine si
noterà un parallelo cambiamento
del ritmo, da binario a
ternario), tipicamente
gesualdiana è la forza di
persuasione drammatica
dell’opera.
IV.
Dolcissima mia
vita,
A che tardate la bramata
aìta?
Credete forse che 'l bel
foco ond’ardo
Sia per finir perché
torcete 'l guardo?
Ahi, non fia mai che
brama il mio desire
O d’amarti o morire.
Un discorso assai simile è da
farsi anche per questo
madrigale. Nota con finezza
Alfred Einstein: "Nell’interesse
di uno stile affatto personale,
che si potrebbe definire
addirittura “egoistico”, tutti i
più arditi mezzi d’espressione
sviluppati nel corso di un
secolo sono qui portati
all’estremo: applicati a un
testo incapace di tollerare tale
trattamento eccessivo, questo
stile diverrebbe assurdo." Ma
già si è sottolineato come
Gesualdo, qui più che altrove,
tenda a scegliere testi di
scarso rilievo letterario, che
possano docilmente piegarsi
entro gli schemi della sua
violenta fantasia musicale. Si
noti il rilievo che assume in
questa composizione l’enfatica
ripetizione di incisi testuali e
musicali identici, o solo
lievemente variati.
V.
O dolorosa
gioia,
O soave dalore
Per cui quest'alma è
mesta e lieta more!
O miei cari sospiri,
Miei graditi martiri,
Del vostro duol non mi
lasciate privo,
Poiché sì dolce mi fa
oarto e vivo.
L'appropriatezza della notazione
critica del teorico secentesco
Giovanni Battista Doni:
"...gl’Italiani senza fallo
sopravanzano tutte l’altre
nationi nella parte melica:
nella quale niuno de’ moderni
puo contendere col Venosa", è
confermata in particolare, da
questo madrigale, contrappunto
di melodie purissime, isolate
nella loro calda bellezza, come
nel1’esordio o abilmente
illuminate, volta a volta, nello
stretto gioco polifonico.
VI.
Qual fora,
donna, un dolce "oimé!"
d’Amore
Se quell’ "oimé!" che da
voi tragge, ahi lasso,
Lieve dolor, così
m’incende il core?
Misero, a ciascun passo
Vo desiando, e so
ch’indarno il bramo,
Che un dì col cor diciate
"Oimé, ch’io t’amo!"
Assai tenue nella tematica che
l'accomuna al classico,
sospiroso madrigale
cinquecentesco, questa
composizione riesce a
distinguersene per la più
nervosa struttura delle parti
contrappuntistiche e per
l’imensità patetica delle
sezioni omoritmiche.
VII.
Felicissimo
sonno
Che ne le luci di madonna
vivi
E noi di luce privi,
Deh, con un sogno
messaggier le mostra
L’afflitta anima nostra!
Fa che in partir da lei
pietà vi resti
E pietosa si desti.
Il madrigale si fa notare per la
limpida strutturazione in tre
parti, l’ultima delle quali
ritornellata e fortemente
contrastante, nelle correnti
figurazioni, alle prime due.
Noteremo per curiosità che il
motivo del sonno, della bella
dolcemente addormentata, fu tra
i prediletti della poesia per
musica barocca: la scena e, in
conseguenza, "L’aria del sonno"
divenne un luogo comune
dell’opera secentesca.
VIII.
Se vi duol il
mio duolo
Voi sola, anima mia,
Potete far che tutto
gioia sia.
Dhb, gradite il mio
ardore
Ch'arderà lieto nel suo
foco il core,
E quel duol che vi spiace
In me sia gioia, in voi
diletto e pace.
Ancora una volta, al di sotto
dell’empito espressivo della
musica gesualdiana che si apre
qui ad accenti di abbandonata
serenità, si scorge una tersa
architettura formale. Questo
ampio ed elaborato madrigale si
articola in due parti nettamente
distinte: ripetuta due volte la
prima, con piccole ma sottili
variazioni nella ripresa, mossa
e franta nei disegni la seconda.
IX.
Occhi del mio
cor vita,
Voi mi negate, oimé,
Vusata aìla!
Tempo è ben di morire, a
che più tardo?
A che serbate il guardo?
Forse per non mirar come
v’adoro.
Mirate almen ch’io moro!
La delicatissima materia
sentimentale del rnadrigale è
sviluppata dal musicista con
mano leggera, con un tremito
sentimentale che sembra tema di
incrinarne la sospesa atmosfera.
Ancora una volta notiamo il
valore che Gesualdo conferisce
all’iterazione di incisi
testuali identici, che la musica
arricchisce a mezzo di finissime
variazioni.
X.
Languisca al
fin chi da la vita parte
E di morte il dolore
L’affligge sì che in
crude pene more.
Ahi, che quello son io,
Dolcissimo cor mio,
Che da voi parto e, per
mia crudel sorte,
La vita lascio e me ne
vado a morte.
La tematica svolta del testo è
tipica del più convenzionale
madrigale cinquecentesco:
l'elaborazione musicale è,
all’opposto, singolarmente atta
ad illuminate quest'ultimo,
supremo momento dell’arte
gesualdiana. Il discorso procede
attraverso un gioco
contrappuntistico-imitativo
estremamente denso: le entrate
dei vari incisi avvengono sempre
"in stretto", senza che lo
sforzo intellettuale implicito a
quest’arduo procedere tolga
alcunché alla loro intensità
espressiva. Passi di raccolto
declamato accordale
rappresentano zone di più
trasparente lirismo, mentre gli
improvvisi contrappunti correnti
sull’inciso "lascio la vita"
determinano un'espressionistica,
violenta rottura del tessuto
espressivo, fasci di luce che
guizzano improvvisi nella scura
atmosfera del madrigale.
XI.
Mercé, grido
piangendo,
Ma chi m’ascolta? Ahi
lasso, io vengo meno;
Morrò dunque tacendo.
Deh, per pietade almeno,
Dolce del cor tesoro,
Potessi dirti pria ch’io
mora: "Io moro!"
La situazione delineata dal
testo ha qualche affinità con il
celebre madrigale "Io tacerò, ma
nel silenzio mio", compreso nel
quarto libro, sia pure in una
prospettiva più lirica e
abbandonata: non è da meno di
esso per bellezza e per
1’audacia del linguaggio, già
rilevata, nel Seicento, da
Giovanbattista Doni.
XII.
O voi, troppo
felici,
Che mirate il mio sole
E cangiate con lui
sguardi e parole,
Quel che a voi
sopravanza, ahi, potessi io
Raccor per cibo a gli
occbi del cor mio.
Il madrigale è articolato in due
parti nettamente distinte,
ognuna delle quali si apre con
una declamazione accordale e si
frange in seguito in un mosso
gioco contrappuntistico.
XIII.
Correte,
amanti, a prova,
A mirar meco quello
Onde s'adorna il mondo e
si fa bello!
Vista dolce ed acerba in
cui si trova
Virtù di forza tale
C’or breve fa la vita or
immortale.
È una cornposizione tutta
sospesa nella leggiadria di un
arioso contrappunto: la seconda
sezione è ritornellata, dando
luogo allo schema formale AAB.
|
|