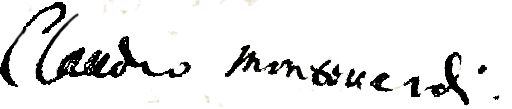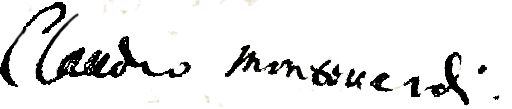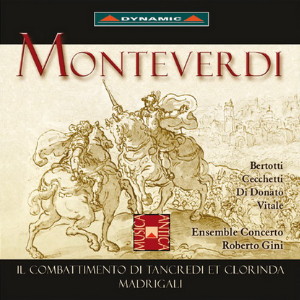 |
|
1 CD - CDS
478 - (c) 2004
|
|
Claudio MONTEVERDI
(1567-1643)
|
|
|
|
|
|
|
|
IL
COMBATTIMENTO DI TANCREDI ET CLORIANDA
- MADRIGALI
|
|
|
|
|
|
|
| Ohimè
ch'io cado, Aria à Soprano solo
con ritornelli |
Ariose
vaghezze... di Carlo Milanuzzi. In
Venetia 1624 |
|
3' 53"
|
|
| Ogni
amante è guerrier |
Madrigali
guerrieri et amorosi, libro ottavo.
In Venetia 1638 |
|
13'
07" |
|
| -
Ogni amante è guerrier; prima parte
à doi Tenori |
|
4' 39" |
|
|
| - Io
che nell'otio nacqui; seconda parte
à Basso solo |
|
6' 53" |
|
|
| - Ma
per qual ampio Egeo; terza parte à
Tenor solo |
|
0' 33" |
|
|
| -
Riedi; ultima parte à 3, doi Tenori
e Basso |
|
1' 02" |
|
|
| Lamento
della Ninfa in genere rappresentativo |
Madrigali
guerrieri et amorosi, libro ottavo.
In Venetia 1638 |
|
5' 27" |
|
| -
Non havea Febo ancora, à tre, doi
Tenori et Basso |
|
1' 38" |
|
|
| -
Amor, à quattro voci, Canto, doi
Tenori et Basso |
|
3' 10" |
|
|
| - Si
tra sdegnosi, à tre, doi Tenori et
Basso |
|
0' 39" |
|
|
| Antonio Brunelli
- Non havea Febo ancora, Aria à
Una voce, Canto o Tenore |
Scherzi,
Arie, Canzonette... Libro Secondo,
Opera Decima. In Venetia, 1614
|
|
3' 44" |
|
Ballo
del Monteverde (First Recording) *
|
Pietro
Milioni: Il vero e facil modo
d'imparare a suonare... la chitarra
spagnuola. In Venetia, 1627 |
|
2' 35" |
|
| -
Ballo |
|
1' 32" |
|
|
| -
Gagliarda |
|
1' 03" |
|
|
| Gira
il nemico insidioso |
Madrigali
guerrieri et amorosi, libro ottavo.
In Venetia 1638 |
|
5' 12" |
|
| -
Gira il nemico insidioso; prima
parte à tre voci Alto, Tenore e Basso |
|
1' 05" |
|
|
| -
Nol lasciamo accostar; seconda parte
Tenor Solo |
|
0' 29" |
|
|
| -
Armi false non son; terza parte Alto
solo |
|
0' 43" |
|
|
| -
Vuol degli occhi; quarta parte Basso
solo |
|
1' 00" |
|
|
| - Non è più tempo; quinta
parte à tre voci |
|
0' 37" |
|
|
| -
Cor mio; sesta & ultima parte à
tre voci |
|
1' 18" |
|
|
| Il
Combattimento di Tancredi et Clorinda |
Madrigali
guerrieri et amorosi, libro ottavo.
In Venetia 1638 |
|
19' 23" |
|
Sigismondo d'India
- Amico hai vinto
|
LE
MUSICHE, Libro quarto a una e due
voci; in Venetia < ? > 1621
*
|
|
5' 27" |
|
| -
Amico hai vinto, prima parte |
|
2' 11" |
|
|
| -
Poco quindi lontan, seconda parte |
|
1' 31" |
|
|
| -
Non morì già, terza ed ultima parte |
|
1' 45" |
|
|
|
|
|
| *
Restored
by Roberto Gini |
|
|
| ENSEMBLE
CONCERTO / Roberto Gini, Conductor |
| - Lavinia
Bertotti, Soprano |
| - Mario
Cecchetti, Vincenzo Di Donato, Tenors |
| - Salvo
Vitale, Bass |
| -
Sandrine Feurer, Stéphanie Erös, Violins |
| -
Stefano Marcocchi, Viola |
| -
Marco Angilella, Violoncello |
| -
Sabina Colonna Preti, Violone |
| -
Maurizio Martelli, Gabriele Palomba, Chitarrone |
| -
Loredana Gintoli, Arpa doppia |
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Pieve Romanica. Palazzo Pignano,
Cremona (Italia) - maggio 2003 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Produced by |
|
DYNAMIC S.r.l., Genova, Italy |
|
|
Sound engineer
|
|
Rino Trasi
|
|
|
Prima Edizione
CD |
|
DYNAMIC - CDS 478 - (1 CD - durata
59' 23") - (c) 2004 - DDD |
|
|
Computer design
|
|
Stefano Grossi |
|
|
Cover |
|
Incontro di Tancredi e Clorinda
XVI Sec., Biblioteca ariostea, Ferrara |
|
|
|
|
|
“Madrigali / guerrieri e
amorosi / con alcuni opuscoli in genere
rappresentativo che saranno / per brevi
episodi fra canti senza gesto / libro ottavo /
di Claudio Monteverde” vede la luce in Venezia
appresso Alessandro Vincenti nel 1638 e si
compone di ben trentasette composizioni che
perseguono un preciso scopo esposto
dall’autore nella preziosissima ed estesa
prefazione. Il pensiero monteverdiario è
fondamentale per capire il clima generale che
informa e permea l’intera raccolta - e, di
conseguenza, anche questo cd - e perciò dovrà
essere citato con una ccrta ampiezza: “Havendo
io considerato le nostre passioni, od
affettioni del animo, essere tre le
principali, cioè Ira, Temperantia, et
Humiltà o supplicatione, come bene gli
migliori filosofi affermano, anzi la natura
stessa de la voce nostra in ritrovarsi,
alta, bassa e mezzana: et come l'arte musica
lo notifica chiaramente in questi tre
elementi, di concitato, molle et temperato,
né havendo in tutte le composizioni de'
passati compositori potuto ritrovare
esempio del concitato genere, ma ben sì
del molle et temperato [...]; et sapendo
che gli contrarij sono quelli che movono
grandementw l’animo nostro, fine del
movere che deve havere la bona musica
[...] perciò mi posi con non poco mio
studio et fatica per ritrovarlo”.
Principale preoccupazione dell’autore è
dunque sollecitare e commuovere gli animi
degli ascoltatori, ma nel contempo trovare
diverse applicazioni di un nuovo stile,
quello concitato appunto. Esso
caratterizzerà dunque non soltanto i brani
apertamente guerrieri, ma si insinuerà anche
in quelli amorosi. Gli esempi qui raccolti,
prevalentenlente desunti dalla raccolta del
1638, danno conto di questa innovazione, ma
nel contempo sottolineano alcune altre
interessanti e avanguardistiche proposte
del cremonese, quale l'articolazionc sempre
più strutturata del madrigale in cicli ben
precisi (Ogni amante; lamento della Ninfa,
Gira il nemico; Combattimento) e
l'invenzione di nuove formule espressive. Ogni
amante è guerrier e Gira il nemico
insidioso sono due cicli divisi
rispettivamente in quattro e cinque parti
ognuna delle quali propone frequenti mutamenti
ritmici in relazione al trascolorare degli
affetti testuali che si riflettono anche sulla
melodia; il declamato vi è usato con una certa
ampiezza, specialmente nelle parti solistiche,
mentre lo stile concitato si manifesta
attraverso declamazioni rapide, esclamazioni
appassionate, figurazioni melismatiche su
specifiche parole.
Il ciclo Non haven Febo ancora
aggiunge a questo carattere un aspetto inedito
che si può sintetizzare nella didascalia
(“modo di rappresentare il presente canto”)
di natura registico-interpretativa che
Monteverdi antepone al brano: “Le tre
parti che cantano fuori dal pianto
della ninfa si sono separatamente
così poste, perché
si cantano al tempo de la mano; le altre tre
parti che vanno commiserando in debole voce
la Ninfa, si sono poste in partitura, acciò
seguitano il pianto di essa, qual va cantato
a tempo del afetto del animo, et non a
qucllo de la mano”. Tre momenti
distinti, dunque, (il primo e l’ultimo scritti
su parti staccate e quello centrale posto in
partitura) che necessitano di altrettanti
atteggiamenti interpretativi: alla scena in
cui “i doi tenori e basso” descrivono
l'afflizione in cui si muove la ninfa (Non
havea Febo ancora), segue il passo (Amor)
in cui la stessa piange la perdita dell’amato.
Sul basso ostinato, costituito dal tetracordo
discendente di passacaglio, si innalza il suo
canto “tutta espressione”, interpuntato dal
commento, ora partecipato ora puramente
dcscrittivo, delle tre voci maschili. La terza
parte (Sì tra sdegnosi) è l'epilogo
brevissimo al pianto della Ninfa dal quale si
traggono riflessioni di carattere generale.
“E per
venire a maggior prova”
dell'espressività, Monteverdi inserisce
nell'ottavo libro di madrigali anche
l'articolato e complesso Combattimento
di Tancredi e Clorinda già
'rappresentato' con molto successo a
Venezia in Palazzo Mocenigo nel 1624 e ben
riuscito, secondo l'autore, alla “immitatione
del ira”, L'argomento e il
testo sono tratti da un episodio
(canto XII, ottave 52-68 con
l'esclusione della 63) della Gerusalemme
liberata di Torquato
Tasso, poeta prediletto dal
Monteverdi (“diedi di
piglio al divin Tasso
come poeta che esprime
con ogni proprietà e
naturalezza con la sua
oratione quelle
passioni che tende a
voler descrivere”) e
paiono
estremamente
adatti ad
utilizzare
compiutamente
“il
concitato”.
Per muovere
gli affetti,
le parole
devono
divenire
drammatiche, “con
gesto”;
si devono
succedere
situazioni
diverse,
talora
contrastanti;
i drammi
interiori dei
personaggi
devono
emergere in
tutta la loro
tragicità. Il
Testo
(narratore)
dunque non si
limita a
raccontare il
dramma, ma nei
momenti più
intensi vi
partecipa
intimamente; i
personaggi
esprimono i
loro
sentimenti
attraverso una
linea vocale,
plastica e
libera, che
permette alla
parola di
essere
compresa
chiaramente e
con tutta la
sua forza
espressiva. Lo
strumentale ha
infine lo
scopo di
evocare una
ricchissima
serie di
effetti
descrittivi
quali il
trotto del
cavallo, il
cozzar d'armi
e di scudi, e
per
raggiungere lo
scopo
desidderato
deve far
ricorso a una
notevole
varietà di
tecniche:
pizzicati,
tremoli,
mutamenti di
colore e di
intensità che
Monteverdi
indica
chiaramente.
L'esecuzione
proposta in
questo cd, al
pari di tutte
le altre,
rispetta in
toto le
prescrizioni
dell'autore,
espresse con
dovizia di
particolari
nella già
citata
prefazione. “[...]
Perciò aviso
dover essere
sonato il
basso continuo
con gli suoi
compagnamenti,
nel modo et
forma in tal
genere che sta
scritto, nel
quale si trova
parimente ogni
altro ordine
che si ha da
tenere nelle
altre
compositioni
d'altro
genere; perché
le maniere di
sonare devono
essere di tre
sorti,
oratoria,
armonicha et
rethminca
[...]”.
Tale cura, che
non soltanto
esalta il
senso del
testo, ma
l'intera
concezione
registica
monteverdiana,
si affianca a
due altri
peculiari
tratti
interpretativi
ricorrenti con
regolarità nel
programma
presentato e
relativi
specificatamente
all'adozione
del tempo
rubato e
all'ornamentazione
storica
desunta dai
trattai del
tempo. Se
entrambe
mirano ad
esaltare i
singoli
passaggi delle
pagine
composite,
sottolineando
gli andamenti
delle parole e
i concetti,
non di meno
abbelliscono
ed accentuano
il significato
della
deliziosa aria
Ohimé ch'io
cado.
Ultimo
elemento di
interesse di
questo cd è
l'aver
inserito
all'interno di
un percorso
monografico,
due exempla
di altrettanti
autori che
musicano lo
stesso testo
scelto da
Monteverdi con
altro intento
e differente
visione
concettuale.
Ed ecco allora
comparire la
delicata e un
po' sbarazzina
Ninfa di
Brunelli o il
Tasso di
Sigismondo
d'India. Facce
diverse della
stessa
medaglia che
hanno tuttavia
un unico
scopo: “aprire
la via
naturale
all'imitatione” e
| |